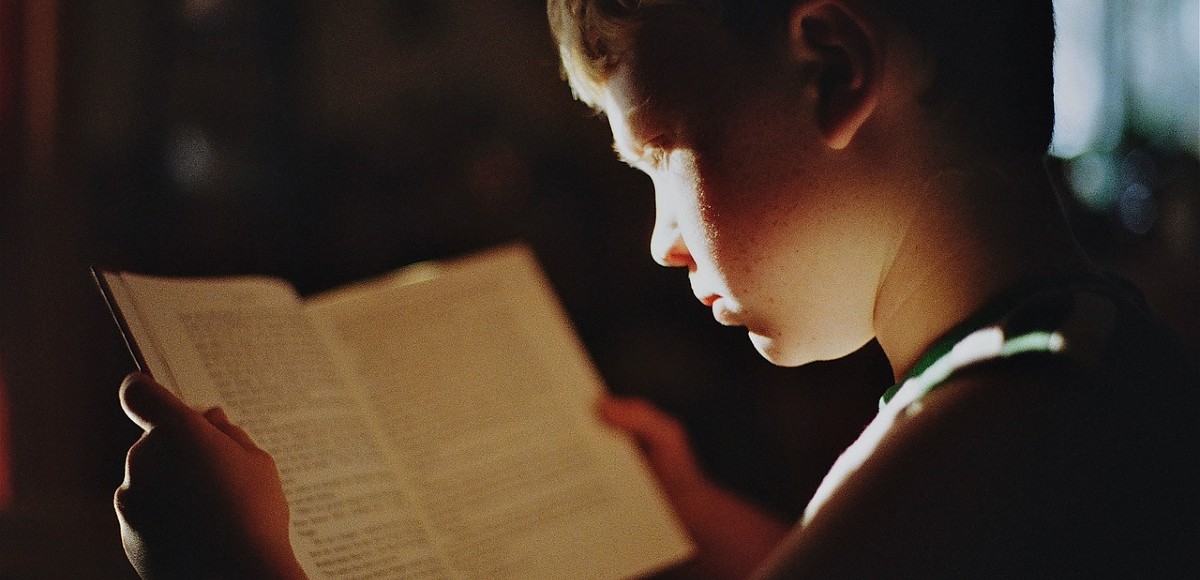La dislessia è caratterizzata da una difficoltà nella lettura fluente e accurata, nonostante un’intelligenza nella norma e un’adeguata istruzione.
Non si tratta di un problema legato all’intelligenza o alla pigrizia, ma di una condizione neurobiologica che incide sui processi di decodifica delle parole. Questo disturbo si manifesta già nei primi anni di scolarizzazione e può persistere per tutta la vita.
Che cos’è la dislessia?
La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che si manifesta con una difficoltà nella lettura accurata e fluente, spesso accompagnata da problemi nella comprensione del testo. Si tratta di una condizione neurobiologica che non dipende da alcun deficit intellettivo, di motivazione o sensoriale. È piuttosto da un’alterazione nel funzionamento di alcune aree cerebrali coinvolte nei processi linguistici.
Su di un livello tecnico, la dislessia è classificata come un disturbo della decodifica fonologica, ovvero la capacità di associare i grafemi (le lettere scritte) ai fonemi (i suoni corrispondenti). Questo deficit compromette:
- la via fonologica: le parole vengono lette attraverso la decodifica in sequenza delle singole lettere. Nel concreto le lettere scritte (i grafemi) sono convertiti nei rispettivi suoni (i fonemi), e sono quindi combinati per formare la parola completa
- la via lessicale: la lettura avviene riconoscendo immediatamente la parola nel suo insieme, senza scomporla in singole lettere. Il cervello accede a un “dizionario mentale” in cui sono memorizzate le rappresentazioni visive delle parole già conosciute, permettendo una lettura più rapida e fluente.
La dislessia non è correlata a problemi di vista o udito e può variare in gravità. Richiede interventi personalizzati che vanno dal supporto didattico all’uso di strumenti compensativi, come software di sintesi vocale e mappe concettuali.
La dislessia in Italia
In Italia, si stima che quasi 3 milioni di persone soffrano di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). La dislessia rappresenta il disturbo più comune.
Tra gli studenti, la prevalenza di DSA è cresciuta significativamente negli ultimi anni: nell’anno scolastico 2022 – 2023, il 6% degli alunni italiani aveva una diagnosi di DSA, con percentuali più alte nelle regioni del Nord e nelle scuole paritarie
Chi sono i personaggi famosi dislessici?
Avere una diagnosi di dislessia non significa avere deficit di ordine intellettivo. Contrariamente a questo luogo comune, ci sono esempi di personaggi noti, della storia e della attualità, che pur avendo sofferto di dislessia, si sono distinti per innovazione e creatività.
È il caso di Leonardo da Vinci, Mozart, Albert Einstein, Walt Disney, John Lennon. Per citare i nomi più conosciuti.
Che cosa sono i DSA?
La dislessia non è l’unico DSA. I disturbi specifici dell’apprendimento sono tre, nel dettaglio:
- La dislessia, che interessa le abilità di lettura (lettura scorretta e lenta, inversione delle lettere, comprensione testuale scritta che presenta difficoltà).
- La disgrafia e disortografia, che minano la capacità di scrittura (errori ortografici, scrittura difficilmente leggibile, lentezza nello scrivere).
- La discalculia, relativa alla difficoltà di calcolo (difficoltà nel memorizzare procedure di calcolo e tabelline, strategie di calcolo immature, scambio dei segni nelle operazioni).
È possibile che più disturbi dell’apprendimento si manifestino nello stesso bambino. Ai DSA risulta associato solitamente anche un deficit di attenzione.
I DSA, si specifica ulteriormente, non sono classificati come patologie, ma come disturbi di origine neurobiologica o costituzionale, con una base genetica. È importante sottolineare che le persone con DSA possiedono capacità cognitive globali pienamente sufficienti.
Perché si diventa dislessici?
Non è stata fatta ancora chiarezza in merito alla eziologia tanto della dislessia quanto dei DSA. Per entrambe, anzi, si può dire che l’eziologia rimane attualmente sconosciuta.
Risulta dunque più opportuno parlare di fattori genetici, vista la possibilità che una espressione anormale di alcuni geni, relativi alla capacità di linguaggio e di lettura, può compromettere la funzione di aree cerebrali alla capacità di lettura e alla capacità di abbinamento, in modo corretto, tra lettere e suoni.
Si segnalano quindi fattori di rischio relativi all’ambiente in cui il bambino vive. Fattori che possono entrare in interazioni con i fattori genetici.
Tipi di dislessia
Si dànno diverse forme di dislessia, che può essere:
- lessicale o superficiale: si distingue per l’incapacità di riconoscere le parole come unità complete. Si ha difficoltà nella lettura di termini irregolari o omofoni non omografi (come “l’una” e “luna”). In questo caso, il soggetto si affida principalmente alla via fonologica, che permette di decodificare le parole attraverso la conversione lettera – suono.
- fonologica: compromette la capacità di associare grafemi e fonemi. Questo si traduce in difficoltà nella lettura di parole nuove, lunghe o pseudoparole (parole inventate ma conformi alle regole linguistiche).
- profonda: comporta un malfunzionamento di entrambe le vie di lettura. Le persone con questa forma commettono errori derivazionali, ad esempio, “mangiamo” invece di “mangiate”. Errori visivi, come “sole” al posto di “sola” e semantici, leggendo parole con significato simile ma errato. ad esempio, “soldato” anziché “bersagliere”.
- percettiva: si manifesta come lettura lenta e frammentata, con balbettio, ripetizioni e autocorrezioni
- linguistica: è segnata da una lettura troppo rapida che determina a omissioni, aggiunte o inversioni di grafemi e sillabe
- mista: combina elementi della dislessia percettiva e linguistica, determinando una lettura complessivamente imprecisa e rallentata.
Come si manifesta la dislessia?
Ci sono segnali comuni e riconoscibili nelle diverse forme di dislessia.
Nei bambini piccoli, questo disturbo si manifesta spesso con difficoltà nel riconoscere le lettere e nel ricordare l’alfabeto. Si potrebbero confondere lettere simili come “b” e “d” oppure “p” e “q”.
Durante l’apprendimento della lettura, i bambini con dislessia possono invertire le sillabe leggendo ad esempio “pasta” come “stapa”, o saltando parole intere durante la lettura di un testo. Si tende, inoltre, a leggere lentamente e in modo frammentato, con pause frequenti e ripetizioni. La memorizzazione delle tabelline o di sequenze come i giorni della settimana può risultare estremamente complessa.
Negli adolescenti e negli adulti, le difficoltà si traducono spesso in errori ortografici frequenti, problemi nella lettura veloce e nella comprensione del testo. Per fare un esempio, potrebbero fraintendere frasi come “Il cane corre dietro al gatto” e pensare che sia il gatto a inseguire il cane.
Che problemi ha un dislessico?
Esistono segnali precoci specifici a indicare una possibile condizione di dislessia, segnali che variano in base all’età.
Nei bambini in età prescolare, la dislessia può manifestarsi con ritardi nella comparsa del linguaggio, pronuncia scorretta, inversione di lettere o parole, e difficoltà nell’apprendimento dell’alfabeto o nella costruzione delle frasi.
In età scolare, i segnali includono una lettura lenta e poco fluida, difficoltà con le sequenze (lettere, giorni), e confusione o rotazione di lettere e cifre.
Non vanno dimenticati possibili disturbi associati, quali:
- Ridotta capacità di concentrazione
- Problemi nell’organizzazione e nella memoria
- Difficoltà nella coordinazione motoria
- Scrittura e calcolo difficoltose.
In assenza di una diagnosi, il bambino potrebbe incorrere in questioni legate all’autostima, per via del senso di inadeguatezza che deriva dalla impossibilità di comprendere la natura di quanto sta vivendo. In un simile contesto, la comunicazione in famiglia può essere uno strumento utile ad arginare il senso di inadeguatezza e di eventuale solitudine che il bambino rischia di patire.
Come percepisce e interpreta il testo una persona dislessica?
Chi soffre di dislessia trova difficoltoso adattarsi a stimoli ripetitivi. Ad esempio, leggere una parola per la prima volta e poi ritrovarla nel corso dello stesso testo può sembrare ogni volta un’esperienza nuova, come se non fosse mai stata vista prima. Questa caratteristica rende la lettura ad alta voce particolarmente complicata e lenta.
Dal punto di vista visivo, un testo appare composto da parole in cui le lettere possono risultare invertite o spostate all’interno della parola stessa, creando confusione e rallentando la comprensione. Tali difficoltà non si limitano alla lettura, ma si riflettono anche nella scrittura, dove si riscontra la stessa tendenza a errori dovuti all’inversione o all’alterazione delle lettere.
Come si svolge una diagnosi di dislessia
Diagnosi e valutazione della dislessia devono essere svolte da uno specialista che si occupi di neuropsichiatria infantile, sia un neuropsicologo o un logopedista. Al bambino sono somministrati dei test per l’indagine delle abilità di lettura, calcolo e scrittura. Anche la funzionalità dei processi cognitivi è oggetto d’indagine dei test:
- Attenzione
- Memoria
- Linguaggio
- Intelligenza generale
- Percezione
- Abilità prassiche.
Per svolgere questo tipo di indagine è necessaria l’autorizzazione della ASL, in base a quanto prevede la legge 170/2010. Una diagnosi di DSA può essere svolta solo quando il bambino ha terminato la seconda elementare, fermo restando che possono essere identificati segnali precoci di questa condizione, come indicato.


Trattamenti per la dislessia
È fondamentale iniziare i trattamenti il prima possibile, adattandoli alla situazione specifica sotto la guida di uno specialista. Gli obiettivi principali includono:
- migliorare velocità e correttezza di lettura
- automatizzare la conversione tra scritto e parlato
- aumentare la consapevolezza fonologica.
Anche i genitori hanno un ruolo attivo, ad esempio leggendo insieme al bambino per almeno 15 minuti al giorno. Questa abitudine stimola l’interesse per la lettura, amplia il linguaggio e favorisce il legame con il testo, soprattutto se fatta a voce alta.
Strumenti come software di videoscrittura e strategie didattiche specifiche, tra cui approcci multisensoriali, mappe concettuali e rappresentazioni visive, risultano particolarmente utili. Queste metodologie possono essere efficaci anche per gli adulti con dislessia. Il percorso di trattamento, quindi, parte sempre da una valutazione specialistica mirata.
(24 Marzo 2025)